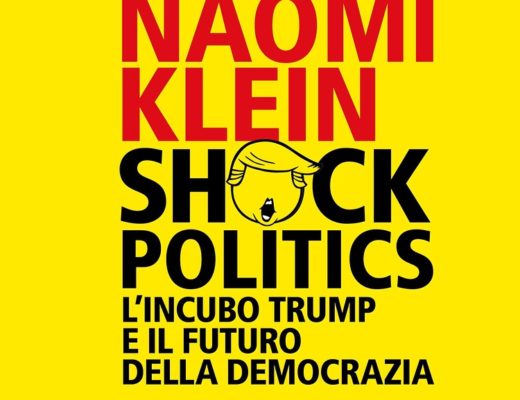«I’m interested in people. It is always people» ripete più e più volte Elizabeth Strout durante un incontro pomeridiano con alcuni giornalisti e blogger. Siamo a Torino, nella casa editrice che da qualche anno ha iniziato a pubblicare i suoi libri. Rossetto rosso, camicia bianca e capelli biondi arruffati, ecco davanti a noi la scrittrice americana che è entrata nei cuori di moltissimi lettori italiani, ponendo sempre al centro delle sue storie i personaggi. Prima Olive Kitteridge, adesso Lucy Barton.
«In America mi definiscono character-driven» afferma sorridendo la Strout. «Parto dal personaggio e su di esso modello la mia storia. Mi interessano le persone, non le idee. Una volta che le ho trovate, queste persone, allora organizzo una struttura che si adatti al meglio alla storia che voglio narrare». Può essere una struttura più tradizionale – come nel caso dei Ragazzi Burgess – o basata su una voce, come per Mi chiamo Lucy Barton. Oppure ancora, ed è lì che sembra esplodere il talento della Strout, in un microcosmo di episodi che racchiudono una costellazione di personaggi e voci. Così come è accaduto nell’amatissimo Olive Kitteridge. E come accade di nuovo nell’ultimo romanzo, appena pubblicato in Italia: Tutto è possibile (Einaudi, traduzione di Susanna Basso, pp. 216, 19 euro). Siamo ad Amgash, cittadina immaginaria dell’Illinois che ha dato i natali a Lucy Barton. Ed è lì che ritroviamo i personaggi di cui avevamo solo sentito parlare attraverso le storie narrate tra Lucy e sua madre. Ci sono tutti: Patty Nicely, Vicky e Pete Barton, Charlie Macauley e Abel Blaine.
Com’è stato per lei ritornare ad Amgash?
Quando scrivevo Mi chiamo Lucy Barton era la voce della protagonista che mi guidava: lei parlava e io scrivevo. Quando invece ho deciso di iniziare la stesura di Tutto è possibile, ho capito che così non avrebbe potuto funzionare. Dovevo abbandonare la voce di Lucy, e scoprire qualcosa in più delle vite di tutti i personaggi. Ma scegliendo la mia voce.
La limpidezza della scrittura fa da contraltare alla complessità dei sentimenti umani. Come riesce a renderlo possibile sulla pagina?
In questa fase della mia vita mi viene molto naturale. Ma in passato non è stato affatto così. Per moltissimi anni ho scritto e scritto e riscritto. E tutt’oggi riscrivo molto. All’epoca mi rendevo conto di scrivere troppo e allora tagliavo, tagliavo e tagliavo. La pratica mi ha aiutato a migliorare, ma è stato un processo che è durato anni. È stato faticoso, certo, e a volte anche frustrante, ma mi ha permesso di arrivare a dove sono oggi, a scrivere cioè una frase che sia clean, che sia ben piazzata, che stia in piedi da sola. Quando scrivo penso molto al mio lettore: voglio sempre lasciare delle bolle d’aria nelle mie storie, degli spazi pensati appositamente per il lettore. Ognuno può contribuire infilando tra le mie pagine la propria esperienza. Così un libro diventa mille libri diversi a seconda del lettore.
In un recente articolo apparso sulla Lettura, sostiene che – a differenza della vita in cui tutti giudichiamo tutti – lei tende a sospendere il proprio giudizio verso i personaggi che popolano le sue storie.
A me interessano le persone. L’ho detto più volte e lo continuerò a ripetere. Una volta trovate, parte tutto il resto. La storia, la struttura e via dicendo. Come posso spiegarvi? Succede così, è così che funziona il mio cervello. Il processo è più o meno questo: creo un personaggio, cerco di capire se mi piace o meno. Mi ci soffermo, perché voglio capire se suscita in me un sentimento, un’emozione – che poi dev’essere l’amore, perché io amo i miei personaggi. Cerco di farmene un’immagine il più visiva possibile. È come una costellazione: distribuisco tutti su un tavolo – molto più piccolo di questo (ride indicando il tavolo delle riunioni del mercoledì).
Qui c’è Patty, lì Charlie, più in là ci sono Vicky e Pete. Se non trovo nulla che mi lega a questi personaggi, non è neanche il caso che io cominci a lavorarci. Come scrittrice non posso e non devo giudicarli. Ed è una scelta liberatoria, credetemi. Perché, a quel punto, essendo esseri umani possono fare tutto quello che vogliono. Anche le azioni più turpi. È un segreto che ho imparato mentre stavo scrivendo Amy e Isabelle, il mio primo romanzo. È stato in quegli anni che ho capito che non mi interessavano i melodrammi. Il sentimentalismo è una scorciatoia che non prendo in considerazione. Non è quello che volevo fare io, come scrittrice. Ero e sono tuttora interessata a qualcosa di diverso. Rifuggo le storie in cui il Bene e il Male sono visibili e assoluti: preferisco concentrarmi su quella materia incasinata che ci rende umani.
In quest’ultima costellazione che ha creato scrivendo Tutto è possibile c’è un personaggio in particolare – al di là di Lucy – che le sta più a cuore?
Charlie Macauley kills me. Non so perché, non me lo so spiegare, ma non riesco a resistergli. Ha qualcosa di più, ha qualcosa di diverso. Non so assolutamente spiegare il perché, forse quello che mi colpisce così tanto di lui è che è così reale. In verità tutti i miei personaggi per me sono molto reali, ma è come se Charlie, ogni volta, mi toccasse nel profondo del cuore.
Nelle sue narrazioni oltre a essere importanti i personaggi, sono fondamentali i luoghi. I suoi primi quattro romanzi sono ambientati nel Maine, dove lei è nata e cresciuta. Invece incontrando Lucy Barton ci spostiamo nel Midwest. Come mai?
Non ho pianificato la cosa a tavolino. Quando all’inizio mi sono messa a impostare – con fatica, lo ammetto – le primissime scene di quello che sarebbe poi diventato Mi chiamo Lucy Barton (una madre e figlia in una stanza d’ospedale newyorkese) non riuscivo a capire in quale direzione muovermi. Finché, a un certo punto, eccola. Un’illuminazione. Mi sono detta: lei, questa mia nuova protagonista, non può venire dal Maine. Lei deve venire da cieli sterminati – di una bellezza assoluta e per questo spaventosa –, da casette piccole e campi di grano. La mia Lucy deve venire dal Midwest.
È stata una rivelazione molto utile. Mi ha chiarito le idee sulla direzione da prendere. La sua visione – questo cielo vastissimo – mi ha fatto comprendere che era come se vedessi le cose con i suoi occhi. E che la voce attraverso cui avrei scritto la storia sarebbe stata la sua, non certo la mia. A quel punto si è sbloccato qualcosa: ho pensato che la mamma di Lucy non doveva aver mai preso l’aereo in tutta la sua vita. Di conseguenza Lucy doveva avere avuto un’infanzia di estrema povertà. Il cielo mi è apparso: tutto, all’improvviso, si è fatto più chiaro.
Se, come ci suggerisce il titolo, tutto è possibile, allora è possibile anche essere felici?
Tutto è possibile riguarda proprio quegli attimi di felicità, quegli stati di grazia che accadono all’improvviso nelle nostre vite. Sono infinitesimali, a volte così rapidi e in apparenza talmente insignificanti che non ce ne accorgiamo, o li diamo per scontati. Ma se siamo disponibili ad accettarli e a riceverli – questi momenti di grazia – allora sì, tutto è davvero possibile.
Fotografia © Leonardo Cendamo